Il ritardo della prosa volgare nel Duecento
La prosa volgare si afferma in Italia solo alla fine del XIII sec. e dunque con netto ritardo rispetto alla poesia, il cui "canone" appare già fissato a metà del secolo con l'opera dei Siciliani e dei siculo-toscani: le ragioni vanno ricondotte anzitutto all'egemonia del latino e della lingua d'oïl nelle opere di argomento storico e dottrinale, diffuse soprattutto nelle regioni del Nord Italia (val la pena ricordare la Cronica in latino di fra Salimbene Adami da Parma, mentre Brunetto Latini scrive i Livres dou trésor in francese), mentre l'uso del volgare nella prosa si diffonde a partire dalla Toscana nel fiorire dell'età comunale, sia per l'affermarsi della poesia che costituiva un importante precedente culturale, sia per l'emergere della società mercantile e della contesa politica che faceva della retorica e dell'uso del linguaggio uno degli strumenti di lotta, mentre il volgare era ormai largamente utilizzato nei documenti legali e notarili. Importanza decisiva ebbero inoltre i volgarizzamenti, ovvero le traduzioni in lingua volgare di varie opere latine e soprattutto francesi (tra queste i romanzi cortesi, che conobbero una grande diffusione in prosa nel tardo Duecento e furono conosciuti e apprezzati anche da Dante), nonché le artes dictandi, ovvero i trattati in latino in cui si insegnava agli scolari l'arte di scrivere in perfetto stile delle epistole di tipo oratorio (anche con attenzione al cursus, cioè al ritmo e agli artifici di suono). L'ars dictandi fu presto applicata anche alla redazione di documenti e discorsi in lingua volgare e come tale aiutò non poco a formalizzare un linguaggio per sua natura mutevole e privo di una grammatica rigida, per cui quando i grandi scrittori di inizio XIV sec. si dedicarono a scrivere opere in prosa raccolsero i frutti di un lungo lavoro iniziato nel secolo precedente, che sfociò soprattutto nei generi della storiografia, della narrativa, delle cronache di viaggio. La nascita delle prosa volgare non soppiantò affatto la prosa latina, che anzi proseguì fiorente e produsse alcune opere importantissime per tutto il XIV sec. (soprattutto con i trattati e le epistole di Dante, poi con l'opera di Petrarca e in parte di Boccaccio) e ancora in pieno Umanesimo, quando addirittura fu il latino ad oscurare in parte il volgare nell'ambito della letteratura umanistica.
L'affermarsi della storiografia: Dino Compagni
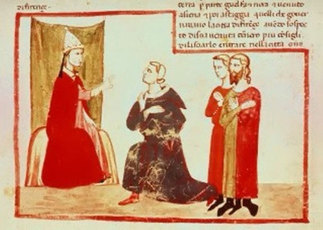 Bonifacio VIII e Carlo di Valois, min. XIV sec.
Bonifacio VIII e Carlo di Valois, min. XIV sec.
Nella letteratura mediolatina la storiografia era un genere molto diverso dall'antichità e considerava le vicende umane come espressione della volontà divina, non come concatenazione di eventi umani per cause economiche e sociali, dunque le cronache partivano quasi sempre dalla creazione del mondo o dall'episodio biblico della Torre di Babele, senza una precisa distinzione tra fatti realmente accaduti e leggendari. Le prime opere storiche in volgare risentono di questa impostazione, anche se nel mondo comunale toscano si avverte l'esigenza di spiegare e raccontare i fatti politici più recenti, con minore attenzione al risvolto religioso della narrazione, specie a Firenze che nella seconda metà del Duecento era diventata la città più ricca e politicamente influente dell'Italia centrale. Qui è attivo soprattutto Dino Compagni (1260 ca. - 1324),
originario di una famiglia del "popolo grasso" (la ricca borghesia mercantile) e guelfo bianco attivo nelle vicende politiche del Comune, finché fu costretto a ritirarsi dalla vita pubblica dopo l'azione di Carlo di Valois che nel 1301 favorì la presa di potere dei Neri (episodio in seguito al quale Dante venne esiliato). Scrisse allora una Cronica delle cose occorrenti ne' tempi suoi, in cui rinunciò all'impianto universalistico e annalistico per trattare gli avvenimenti del periodo 1280-1312, concentrandosi in particolare sugli anni 1300-1308 che videro a Firenze il conflitto tra Bianchi e Neri e interrompendo la trattazione quando Arrigo VII di Lussemburgo, sceso in Italia per ristabilirvi l'autorità imperiale, morì improvvisamente nel 1313. L'opera è piena della passione di parte dell'ex-uomo politico e contiene veementi apostrofi dirette ai concittadini fiorentini (► TESTO: Le prepotenze dei guelfi neri), nonché prese di posizione e condanne nette verso i capi-fazione più violenti della parte avversa, tra cui spicca soprattutto quel Corso Donati preso di mira anche da Dante in più di un passo della Commedia. Gli fu a lungo attribuito, ma pare senza fondamento, anche il poemetto intitolato L'intelligenza (► PERCORSO: La poesia religiosa) e fu autore anche di rime.
originario di una famiglia del "popolo grasso" (la ricca borghesia mercantile) e guelfo bianco attivo nelle vicende politiche del Comune, finché fu costretto a ritirarsi dalla vita pubblica dopo l'azione di Carlo di Valois che nel 1301 favorì la presa di potere dei Neri (episodio in seguito al quale Dante venne esiliato). Scrisse allora una Cronica delle cose occorrenti ne' tempi suoi, in cui rinunciò all'impianto universalistico e annalistico per trattare gli avvenimenti del periodo 1280-1312, concentrandosi in particolare sugli anni 1300-1308 che videro a Firenze il conflitto tra Bianchi e Neri e interrompendo la trattazione quando Arrigo VII di Lussemburgo, sceso in Italia per ristabilirvi l'autorità imperiale, morì improvvisamente nel 1313. L'opera è piena della passione di parte dell'ex-uomo politico e contiene veementi apostrofi dirette ai concittadini fiorentini (► TESTO: Le prepotenze dei guelfi neri), nonché prese di posizione e condanne nette verso i capi-fazione più violenti della parte avversa, tra cui spicca soprattutto quel Corso Donati preso di mira anche da Dante in più di un passo della Commedia. Gli fu a lungo attribuito, ma pare senza fondamento, anche il poemetto intitolato L'intelligenza (► PERCORSO: La poesia religiosa) e fu autore anche di rime.
La Nuova Cronica di Giovanni Villani
 Totila fa distruggere Firenze, min. XIV sec.
Totila fa distruggere Firenze, min. XIV sec.
Più complessa e interessante la figura del fiorentino Giovanni Villani (1280 ca. - 1348), socio della Compagnia dei Peruzzi e dei Bardi nel cui fallimento fu coinvolto; guelfo di parte nera, ebbe vari incarichi politici e si recò nel 1300 a Roma per il Giubileo indetto da papa Bonifacio VIII, restando colpito dalla magnificenza della città e decidendo in seguito di scrivere un'opera che raccontasse la storia di Firenze, che secondo la leggenda era nata come colonia romana e la cui origine era rivendicata con orgoglio. Compose allora la Nuova cronica a partire dal 1308 circa sino alla morte (avvenuta durante l'epidemia di peste del 1348), che segue uno schema medievale e racconta la storia della città a partire dalla Torre di Babele, per poi scendere via via più nei dettagli man mano che la narrazione si avvicina agli anni in cui visse l'autore. L'opera è interessante in quanto offre un quadro della vita politica e sociale della Firenze di fine XIII-inizio XIV sec. assai ricco di particolari anche statistici e demografici, per cui la Nuova cronica si può considerare la prima grande opera storiografica della letteratura volgare, nonostante risenta ancora di schemi culturali del passato (tale impostazione sarà abbandonata definitivamente solo in età umanistica). L'opera, che si interrompe all'anno 1346, venne proseguita dal fratello di Giovanni, Matteo, e poi dal nipote Filippo, che giunsero sino al 1364.
Le cronache di viaggio: il Milione di Marco Polo
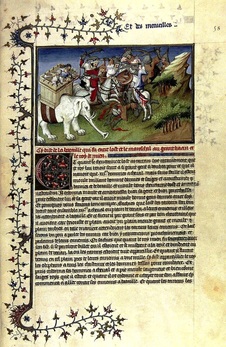 Miniatura del "Milione" (XIV sec.)
Miniatura del "Milione" (XIV sec.)
Nel tardo Duecento tutto ciò che riguardava l'Oriente e i popoli che vi abitavano, nonché le tradizioni e i costumi di quelle terre remote e leggendarie, era avvolto nel mistero e fonte di curiosità da parte dei lettori, per cui si può comprendere il grande interesse che agli inizi del Trecento suscitò la cronaca che il mercante veneziano Marco Polo (1254-1324) produsse dei suoi viaggi in Asia, alla corte del Gran Khan dei Mongoli: l'opera, nota col titolo popolare di Milione (da una storpiatura di Emilione, il soprannome dei Polo) fu dettata dall'autore a Rustichello da Pisa quando i due erano in carcere a Genova, entrambi prigionieri della Repubblica Marinara in seguito a una battaglia navale, e inizialmente scritta in lingua d'oïl col titolo Le divisament dou monde, "La descrizione del mondo", o anche Livre des merveilles, "Libro delle meraviglie". In seguito la cronaca subì vari volgarizzamenti, in toscano e in veneziano (la lingua materna dell'autore) e conobbe una vasta diffusione soprattutto nell'Italia del Nord, benché non abbia contribuito a gettare le basi di un vero e proprio genere. Il Milione si distende per oltre 200 capitoli e racconta in modo minuzioso il viaggio di andata e ritorno di Marco Polo, accompagnato dal padre e dallo zio, da Venezia a Pechino tra il 1271 e il 1295, che si configura anzitutto come una missione commerciale compiuta anche per conto di Venezia, potenza economica e marittima in stretto contatto coi regni del lontano Oriente. L'opera è dunque una cronaca di viaggio, ma contiene anche descrizioni di popoli, usanze, regioni che ne fanno un trattato etno-geografico in anticipo sui tempi, non trascurando particolari leggendari ed esotici che soddisfacevano il gusto e la curiosità del pubblico borghese e mercantile del tempo (ciò avviene, per esempio, nella descrizione del Giappone non visitato direttamente dall'autore). Spesso emerge la mentalità mercantile di Marco Polo, che guarda ogni cosa con la mentalità dell'uomo d'affari che cerca ovunque opportunità economiche, per cui l'opera si può considerare in parte anche una sorta di manuale di mercatura e si rivolge, infatti, a un pubblico borghese che appartiene a quel mondo. Il successo della cronaca nel tempo è stato enorme e l'opera è stata tradotta in varie lingue, mentre è da ricordare che Italo Calvino ne ha tratto spunto per costruire la cornice del romanzo Le città invisibili (1972), opera "aperta" in cui l'immaginario dialogo tra Marco Polo e il Khan offre il pretesto per divagazioni sul mondo contemporaneo e i suoi drammatici problemi. Ai viaggi di Marco Polo la RAI dedicò un imponente sceneggiato nel 1982, per la regia di G. Montaldo, che fu a lungo la produzione più costosa dell'azienda pubblica e riscosse numerosi consensi (► TELEVISIONE: Marco Polo).
La prosa narrativa: il Novellino e il Libro dei sette savi
 Tristano e Isotta, min. XV sec.
Tristano e Isotta, min. XV sec.
La prosa narrativa e la novellistica si affermano alla fine del Duecento, come punto di arrivo di una lunga tradizione precedente che si rifà tanto alla letteratura latina che a quella francese: i modelli sono diversi e vanno dai racconti agiografici e dagli exempla morali (brevi racconti latini in cui l'aneddoto fornisce una norma di comportamento), ai lai e ai fabliaux della lingua d'oïl, senza dimenticare le vidas e le razos della letteratura occitanica (rispettivamente le biografie dei trovatori, spesso ricche di elementi leggendari, e le spiegazioni in prosa delle loro liriche). Un notevole influsso sulla novellistica esercitarono anche le opere di derivazione orientale lei cui traduzioni latine circolavano ampiamente in Europa nel XIII sec., tra cui le Mille e una notte la cui traduzione in forma definitiva giunse più tardi, nel XVI sec. Gran parte di questa tradizione confluisce poi nel Novellino, una raccolta anonima di cento racconti scritti certamente a Firenze verso la fine del XIII sec. e attribuiti ad almeno due autori diversi, uno più rozzo e borghese e un altro più nobile e raffinato (ma si pensa anche all'evoluzione di un solo scrittore): l'opera non contiene alcuna cornice narrativa e le novelle vedono protagonisti di tutti i ceti sociali, popolani, ricchi borghesi e mercanti, uomini e donne nobili che vivono nelle corti. I racconti si ispirano in parte al modello degli exempla, specie per la loro relativa brevità, tuttavia l'intento dell'opera non è edificante ma di intrattenimento di un pubblico borghese, e se vi è un intento educativo non è di tipo religioso ma piuttosto retorico, quello cioè di insegnare i "fiori di parlare" e i "belli risposi" (le risposte argute, ingegnose). In effetti i racconti riflettono spesso una mentalità mercantile e borghese che a tratti rivendica i propri diritti a scapito di un'aristocrazia feudale attaccata ai propri privilegi di casta, come nella novella del medico di Tolosa, non di rado con quel gusto della battuta salace e della beffa tipicamente toscano e che si ritroverà ampiamente nel Decameron di G. Boccaccio; non mancano tuttavia novelle di raffinata ambientazione cortese ed altre di argomento leggendario e letterario, tra cui spicca quella famosa di Tristano e Isotta ispirata al ciclo bretone dei romanzi cortesi in lingua d'oïl (► TESTO: Tristano e Isotta).
Di carattere diverso è invece il Libro dei sette savi di Roma, anch'esso anonimo e frutto della traduzione in toscano di un testo francese che a sua volta riprende un racconto di origine orientale (forse indiano): un giovane principe, reo di aver rifiutato la seduzione della matrigna, è accusato da questa di violenza e condannato a morte, mentre sette savi gli impongono il silenzio per una settimana e, per differire l'esecuzione, raccontano a turno al re una novella al giorno sulla malvagità delle donne, alternandosi con la matrigna che racconta anche lei una novella al giorno di segno opposto per indurre lo sposo a eseguire la sentenza. Trascorsi otto giorni, il giovane può spiegarsi e la sua innocenza viene creduta, mentre a essere condannata è la donna. L'opera è interessante soprattutto per la struttura a cornice che giustifica le novelle, chiaramente ispirata allo schema delle Mille e una notte e a sua volta fonte di ispirazione per il Decameron.
Di carattere diverso è invece il Libro dei sette savi di Roma, anch'esso anonimo e frutto della traduzione in toscano di un testo francese che a sua volta riprende un racconto di origine orientale (forse indiano): un giovane principe, reo di aver rifiutato la seduzione della matrigna, è accusato da questa di violenza e condannato a morte, mentre sette savi gli impongono il silenzio per una settimana e, per differire l'esecuzione, raccontano a turno al re una novella al giorno sulla malvagità delle donne, alternandosi con la matrigna che racconta anche lei una novella al giorno di segno opposto per indurre lo sposo a eseguire la sentenza. Trascorsi otto giorni, il giovane può spiegarsi e la sua innocenza viene creduta, mentre a essere condannata è la donna. L'opera è interessante soprattutto per la struttura a cornice che giustifica le novelle, chiaramente ispirata allo schema delle Mille e una notte e a sua volta fonte di ispirazione per il Decameron.
La narrativa dopo il Decameron: Franco Sacchetti
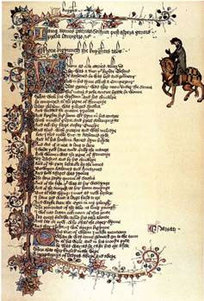 Trecentonovelle, min. XIV sec.
Trecentonovelle, min. XIV sec.
Il Decameron fu senza alcun dubbio l'opera in prosa più importante del XIV sec. e contribuì a fondare un genere (quello della novellistica in volgare) che in precedenza aveva pochi modelli cui ispirarsi, diventando inevitabilmente a sua volta un modello irrinunciabile per tutti coloro che vollero cimentarsi nello stesso tipo di opera: del resto il capolavoro di Boccaccio raccoglieva gli spunti offerti dalla tradizione narrativa sino a quel momento, inclusa la struttura a cornice che gli derivava dal Libro dei sette savi e dalla novellistica orientale, non trascurando neppure la celebrazione della parola e la varietà di ambientazioni (popolari, borghesi, aristocratiche) che gli derivava dal Novellino (► AUTORE: Giovanni Boccaccio; ► OPERA: Decameron). Dopo Boccaccio la narrativa del Trecento vide un solo autore significativo, quel Franco Sacchetti (1332 ca. - 1400) che nacque forse in Dalmazia e visse a lungo a Firenze, scrisse opere di vario genere (poemetti, rime...) e verso la fine del secolo iniziò il Trecentonovelle, una raccolta di racconti privi di cornice narrativa che rimase incompiuta e annovera poco più di duecentoventi racconti, inclusi i frammenti. Le novelle sono di relativa brevità e i personaggi sono per lo più di origine popolare o piccolo-borghese, come del resto l'autore stesso, che quindi non domina la materia dall'alto di una cultura superiore ma guarda la scena dall'interno, con l'occhio di un "uomo discolo e grosso" (la definizione è dello stesso Sacchetti). Il mondo del Trecentonovelle è fatto di burle, scherzi, equivoci, con una certa scioltezza di linguaggio e una morale finale che in genere è un po' facile, incline a lamentare la corruzione del mondo; Sacchetti è in fondo l'esponente di un secolo (il Trecento) che sta declinando e prepara la rivoluzione umanistica del periodo successivo, alla quale lo scrittore è sostanzialmente estraneo per la sua estrazione mercantile e borghese. Tra le novelle più note vi sono quelle dedicate a personaggi noti della letteratura e dell'arte, tra cui Dante, Guido Cavalcanti, Giotto, e quelle del "ciclo" di Dolcibene, una specie di giullare e buffone dotato di grande verve inventiva e di un talento particolare per ordire beffe, oltre che per trarsi d'impaccio (► TESTO: Dolcibene a Padova).
La prosa latina nel Trecento
 Ritratto di F. Petrarca (XV sec.)
Ritratto di F. Petrarca (XV sec.)
Accanto alla produzione in prosa volgare per tutto il XIV sec. è attivo un filone di prosa latina che da un lato prosegue la tradizione della letteratura mediolatina di argomento religioso, specie all'inizio del Trecento (l'autore più significativo in questa fase è sicuramente Dante Alighieri, ► VAI ALL'AUTORE), mentre in un secondo momento essa dà luogo ad opere più innovative che anticipano i caratteri dell'Umanesimo del XV sec., specie con gli scritti di Francesco Petrarca (► VAI ALL'AUTORE) che si può già considerare uno scrittore pre-umanista, il che vale in parte anche per l'ultimo Boccaccio. Tra i generi preferiti da questo filone letterario in latino rientra anzitutto l'epistola, concepita come testo "pubblico" da indirizzare idealmente a una platea vasta di lettori e spesso concernente temi rilevanti sotto il profilo culturale e politico, aspetto che si ritrova nelle epistole latine di Dante (aventi come destinatari i cardinali italiani, l'imperatore Arrigo VII...) e nell'epistolario petrarchesco, opera strutturata dall'autore come una vera raccolta e modellata sull'esempio delle lettere di Cicerone da lui stesso riscoperte. Altro genere decisamente sfruttato è poi il trattato dedicato a temi specifici, che possono essere politico-linguistici (ad es. il De vulgari eloquentia e la Monarchia di Dante) oppure di argomento ascetico e religioso, come il De vita solitaria o il De otio religioso di Petrarca, in cui l'autore abbandona il vecchio schema delle opere medievali ancora presente nei trattati danteschi e anticipa quello moderno e ispirato alla lett. classica dell'Umanesimo, poi ripreso e ampliato da scrittori del tardo Trecento-primo Quattrocento come Coluccio Salutati, Leonardo Bruni e Leon Battista Alberti (► PERCORSO: L'Umanesimo). Moderna e innovativa è anche la forma di un altro importante trattato di Petrarca, quel Secretum che inscena un dialogo fittizio tra l'autore e S. Agostino e la cui struttura si rifà dichiaratamente a quella di tanti dialoghi di Cicerone come il Laelius de amicitia, anticipando le scelte di altri scrittori latini e volgari della letteratura quattro-cinquecentesca (il trattato rinascimentale avrà quasi sempre forma dialogica).
Altrettanto importante è la produzione di carattere erudito di commento ad opere del passato o a vari aspetti della storia e della mitologia classica, che vede soprattutto in Petrarca un iniziatore nel Trecento (importanti le sue compilazioni sui personaggi della storia antica, come il De viris illustribus ispirato all'opera omonima di Cornelio Nepote) e la cui opera segna una grande distanza rispetto all'opera di Dante, che continuava la lettura in chiave cristianizzante degli scritti classici, mentre lo stesso Boccaccio subirà l'influenza del poeta aretino suo amico e produrrà opere erudite quali la Genealogia deorum gentilium, trattato mitografico sulle divinità classiche di gusto pre-umanistico e lontano dalle interpretazioni religiose dell'età precedente (► AUTORE: Giovanni Boccaccio). Petrarca è poi il fondatore in un certo senso della filologia intesa come la ricostruzione su base scientifica del testo e del contenuto delle opere latine classiche, aspetto che verrà ulteriormente approfondito in età umanistica e troverà soprattutto in Angelo Poliziano l'esponente di spicco nel Quattrocento, anche se il poeta toscano unirà alla profonda conoscenza del latino quella del greco ancora estranea a Petrarca come a Boccaccio (e il greco, infatti, verrà riscoperto nel XV sec. soprattutto in seguito alla caduta di Costantinopoli nel 1453 e all'arrivo in Italia di intellettuali di lingua greca esuli dalla loro patria; ► AUTORE: Angelo Poliziano).
Altrettanto importante è la produzione di carattere erudito di commento ad opere del passato o a vari aspetti della storia e della mitologia classica, che vede soprattutto in Petrarca un iniziatore nel Trecento (importanti le sue compilazioni sui personaggi della storia antica, come il De viris illustribus ispirato all'opera omonima di Cornelio Nepote) e la cui opera segna una grande distanza rispetto all'opera di Dante, che continuava la lettura in chiave cristianizzante degli scritti classici, mentre lo stesso Boccaccio subirà l'influenza del poeta aretino suo amico e produrrà opere erudite quali la Genealogia deorum gentilium, trattato mitografico sulle divinità classiche di gusto pre-umanistico e lontano dalle interpretazioni religiose dell'età precedente (► AUTORE: Giovanni Boccaccio). Petrarca è poi il fondatore in un certo senso della filologia intesa come la ricostruzione su base scientifica del testo e del contenuto delle opere latine classiche, aspetto che verrà ulteriormente approfondito in età umanistica e troverà soprattutto in Angelo Poliziano l'esponente di spicco nel Quattrocento, anche se il poeta toscano unirà alla profonda conoscenza del latino quella del greco ancora estranea a Petrarca come a Boccaccio (e il greco, infatti, verrà riscoperto nel XV sec. soprattutto in seguito alla caduta di Costantinopoli nel 1453 e all'arrivo in Italia di intellettuali di lingua greca esuli dalla loro patria; ► AUTORE: Angelo Poliziano).
Il declino della prosa volgare nel primo Quattrocento
La prima metà del XV sec. vede l'affermarsi soprattutto dell'Umanesimo latino (► PERCORSO: L'Umanesimo) e la letteratura volgare viene inevitabilmente messa in ombra, fatto che vale tanto più per la prosa che dopo Sacchetti non vide più alcun autore significativo e dovette attendere lo sviluppo della trattatistica del Cinquecento per conoscere una rinascita: ciò non significa che il primo Quattrocento sia povero di scritti in prosa (ce ne furono anzi moltissimi, specie memorie e novelle), ma questa abbondante produzione manca di profondità culturale e riflette spesso un'ingenua imitazione del modello boccaccesco, per cui è difficile individuare autori e opere degni di nota. Tra essi merita una citazione Cennino Cennini (morto agli inizi del secolo), autore di un Libro dell'arte che vuol essere un trattato tecnico di pittura e da cui traspare la grande ammirazione per Giotto, e un Giovanni da Prato (1367-1446) cui è attribuito un romanzo intitolato Paradiso degli Alberti, in cui un'allegra brigata soggiorna in una villa degli Alberti nel Casentino, detta appunto "Paradiso", dove discute di vari temi e racconta novelle chiaramente ispirate al Decameron. Novelliere fu anche il lucchese Giovanni Sercambi (1348-1424), autore di una raccolta di 155 racconti inseriti in una cornice e che riflette la mentalità mercantile dello scrittore, mentre un certo Antonio Manetti (1423-1497) avrebbe scritto una delle redazioni della Novella del grasso legnaiuolo, che ebbe una notevole diffusione e racconta un'atroce burla fatta da alcuni buontemponi tra cui Filippo Brunelleschi ai danni di un falegname detto "Il Grasso". Molto famoso anche un volumetto di motti intitolato Facezie del piovano Arlotto, attribuito a un Arlotto Mainardi (1396-1484) che fu parroco di Cresci e che è ricordato tra l'altro da Lorenzo de' Medici nei Beoni e da Pulci nel Morgante, nonché in uno scritto di Poliziano. Da ricordare, infine, Vespasiano da Bisticci (1422-1498), attivo a Firenze come trascrittore di testi e in seguito proprietario di un laboratorio di amanuensi in grado di produrre libri manoscritti per la biblioteca di Cosimo de' Medici, segno del bisogno crescente di un'industria del libro prima della diffusione della stampa: scrisse le Vite di uomini illustri del secolo XV, raccolta di biografie di papi, re, vescovi, principi che anticipa opere di genere consimile che si svilupperanno nel secolo seguente ed esprime bene la cultura umanistica che sarebbe presto tornata al volgare per produrre opere di pregio, specie nel versante della poesia.






